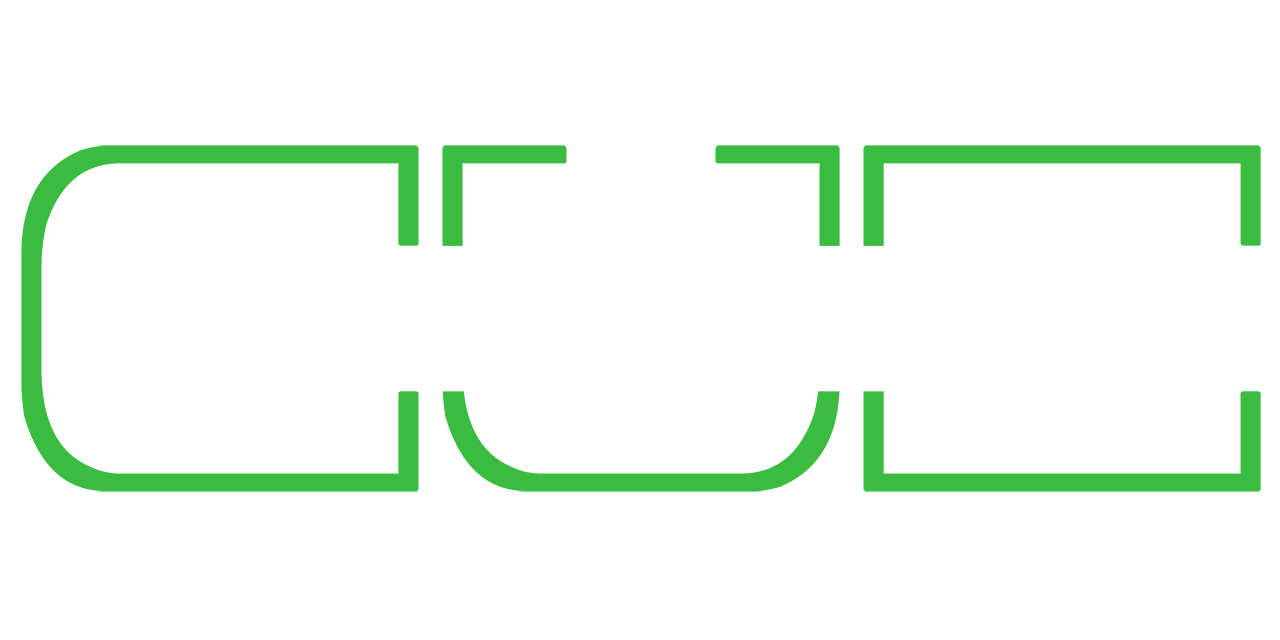La più grande tempesta solare dell’antichità: una supereruzione solare millenaria

Illustrazione di una tempesta solare (Canva FOTO) - energycue.it
Questa è stata con molta probabilità la più grande tempesta solare. Questa potentissima eruzione solare ha lasciato delle tracce evidenti.
C’è qualcosa di affascinante nel pensare che gli alberi, con i loro anelli silenziosi, possano raccontarci eventi accaduti migliaia di anni fa. Proprio tra i boschi sepolti delle Alpi francesi, un gruppo internazionale di ricercatori ha scoperto un segnale sorprendente: un picco di radiocarbonio vecchio di ben 14.300 anni. Un’indicazione netta, impressa nel legno di pini subfossili, che suggerisce la presenza di una tempesta solare gigantesca, la più potente mai rilevata finora.
Questo genere di fenomeni, noti come Miyake Events, prende il nome da Fusa Miyake, la scienziata giapponese che per prima ne identificò uno. Ma quello appena scoperto supera tutti quelli precedenti: è almeno il doppio più intenso dei famosi eventi del 774 e del 993 d.C. E non si parla di una lenta variazione: il segnale è salito all’improvviso, tutto in un solo anno. Una cosa fuori dal comune, che ha attirato subito l’attenzione della comunità scientifica.
Gli alberi sono stati trovati lungo il fiume Drouzet, nel sud-est della Francia, conservati nel letto eroso del corso d’acqua. Non si tratta di fossili veri e propri, ma di tronchi subfossili, cioè legni in uno stato intermedio di conservazione. Analizzando singolarmente gli anelli annuali di queste piante, i ricercatori sono riusciti a ricostruire un’intera sequenza dendrocronologica di circa 700 anni, con un livello di precisione quasi annuale. Ed è lì, proprio nel cuore di quel periodo, che è spuntato fuori il picco anomalo.
Ma perché tutto questo è così importante oggi? Beh, una tempesta solare di quella portata, se si ripetesse oggi, non ci darebbe solo spettacolari aurore boreali. Potrebbe mandare in tilt satelliti, sistemi di navigazione, reti elettriche e comunicazioni globali. Ecco perché studiare eventi del genere nel passato è fondamentale: ci aiuta a prepararci, o almeno a capire meglio con cosa potremmo avere a che fare.
Cosa raccontano gli anelli degli alberi
L’indagine ha preso forma grazie al lavoro congiunto di diversi enti, tra cui il Collège de France, l’Università di Leeds, e diversi istituti francesi di ricerca. Il cuore dello studio si trova in una pubblicazione uscita su Philosophical Transactions of the Royal Society A, e si basa sull’analisi di 15 pini ritrovati nel letto del fiume Drouzet, dove erano rimasti protetti per millenni da fango e sedimenti.
Ogni tronco è stato sezionato anello per anello, quasi come si sfoglia un diario segreto del passato. Alla fine sono state ottenute circa 400 datazioni al radiocarbonio. Il risultato più clamoroso? Un’impennata brusca nei livelli di Δ¹⁴C proprio nel 14.300 a.C., seguita da una lenta discesa. Ma non è tutto: subito dopo, tra 14.010 e 13.910 anni fa, si è registrato un altro lungo aumento, questa volta più graduale e durato circa un secolo. Due eventi diversi, quindi: uno breve e intenso, l’altro lungo e probabilmente legato a un calo prolungato dell’attività solare.

Una tempesta fuori scala
Il primo di questi eventi, quello del 14.300 a.C., è stato interpretato come una tempesta solare eccezionalmente potente. Una sorta di super-eruzione solare, capace di lanciare una quantità enorme di particelle energetiche verso la Terra. Secondo gli studiosi, si tratta con ogni probabilità di un Solar Energetic Particle (SEP) event, il più potente mai identificato, superiore perfino al Carrington Event del 1859, che già all’epoca, come ripoortato da un lavoro di Bard del 2023, causò interruzioni ai telegrafi e un’aurora visibile fino ai tropici. Questa tempesta preistorica avrebbe lasciato la sua impronta non solo negli alberi delle Alpi, ma anche nel ghiaccio della Groenlandia, dove è stato rilevato un picco di berillio-10 (10Be) perfettamente corrispondente, datato tra 14.301 e 14.292 anni fa.
Il secondo evento, quello più lungo e meno esplosivo, è stato invece associato a un periodo di attività solare molto bassa, simile a quello noto come Minimo di Maunder, osservato nel XVII secolo. Anche in questo caso, la sovrapproduzione di isotopi cosmogenici come ¹⁴C e 10Be suggerisce una ridotta schermatura del campo magnetico solare, che avrebbe lasciato passare più raggi cosmici verso l’atmosfera terrestre. Curiosamente, questo evento sembra coincidere con l’Older Dryas, una breve fase fredda che si inserisce tra due periodi climaticamente più miti durante la deglaciazione.