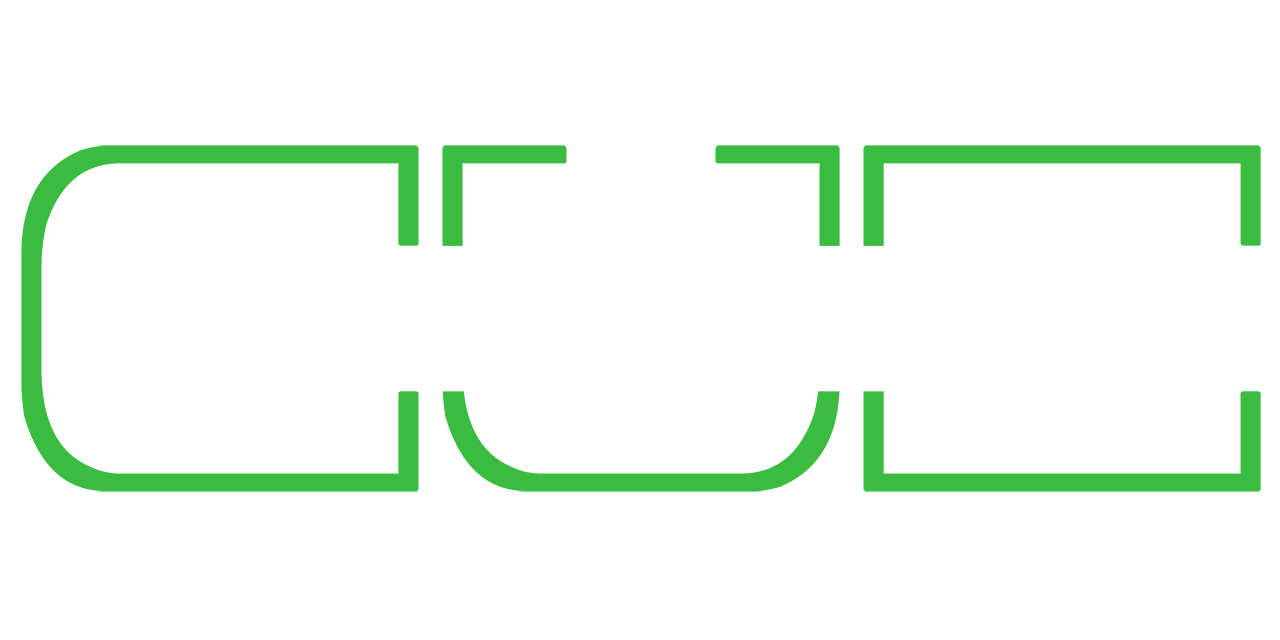Il riscaldamento globale potrebbe risvegliare i vulcani nascosti sotto l’Antartide

Illustrazione di un'eruzione vulcanica (Pixabay FOTO) - energycue.it
Lo scioglimento dei ghiacciai è un problema dal punto di vista mondiale, soprattutto se ad essi sono collegati fenomeni vulcanici.
Che i vulcani siano imprevedibili è cosa nota. Ma che possano risentire direttamente del clima e del ritiro dei ghiacciai… suona quasi paradossale, eppure è proprio ciò che suggerisce uno studio condotto sulle Ande cilene. Il protagonista è Mocho-Choshuenco, un vulcano apparentemente tranquillo, ma con una lunga storia di eruzioni nascoste sotto il peso millenario della calotta glaciale patagonica.
Il legame tra ghiaccio e fuoco non è del tutto nuovo: esempi recenti arrivano dall’Islanda, dove lo scioglimento dei ghiacci ha già mostrato di influenzare la frequenza eruttiva. Tuttavia, questi casi si concentravano perlopiù su ambienti oceanici e isolati. Il caso cileno, invece, porta il discorso su un continente vero e proprio, aprendo nuove domande su cosa potrebbe accadere in altre aree glaciali montane, o addirittura in Antartide.
Lo studio è stato presentato da Pablo Moreno-Yaeger alla conferenza Goldschmidt 2025 a Praga, ed è frutto di anni di lavoro sul campo. Gli scienziati hanno trascorso settimane in quota, accampati tra vulcani attivi e quiescenti, raccogliendo campioni di roccia e dati geochimici per ricostruire un quadro più ampio dell’interazione tra clima e dinamiche magmatiche.
Al centro della ricerca c’è un’idea affascinante: lo spessore del ghiaccio, durante l’ultima era glaciale, avrebbe agito come un coperchio sulla camera magmatica, bloccando temporaneamente le eruzioni e favorendo invece l’accumulo di grandi volumi di magma. Quando il ghiaccio ha iniziato a ritirarsi, circa 13.000 anni fa, quella pressione si è improvvisamente ridotta… e il vulcano ha reagito.
Magma sotto pressione
I dati raccolti raccontano una storia precisa. Tra i 26.000 e i 18.000 anni fa, in pieno massimo glaciale, il ghiaccio raggiungeva uno spessore di oltre 1.500 metri. Durante questo periodo, il vulcano eruttava con meno frequenza, ma nel sottosuolo le cose si stavano muovendo. Le rocce analizzate mostrano che i magmi basaltico-andesitici si cristallizzavano a profondità comprese tra 10 e 15 chilometri. È in questi anni che ha iniziato a formarsi un serbatoio magmatico silicico di oltre 15 km³.
Poi, tra i 13.500 e gli 11.500 anni fa, appena dopo il ritiro del ghiaccio, si sono verificate due eruzioni esplosive da oltre 5 km³ ciascuna, con magma ricco di anfibolo. Secondo i ricercatori, l’abbassamento della pressione dovuto allo scioglimento del ghiaccio avrebbe favorito la fuoriuscita dei gas disciolti nel magma, innescando così la formazione di dicchi e l’eruzione improvvisa del materiale accumulato. Un meccanismo che, in sostanza, trasforma il ghiaccio in un interruttore per il fuoco.

Uno scenario globale da riconsiderare
Quel che rende questo studio particolarmente rilevante è il potenziale che ha di essere replicato altrove. Meccanismi simili, come riportato dal The Guardian, potrebbero verificarsi in regioni ancora oggi coperte da ghiaccio: Antartide occidentale, Alaska, Russia orientale, perfino parti della Nuova Zelanda. Il rischio, in uno scenario di riscaldamento globale rapido, è quello di assistere a un aumento non solo della frequenza, ma anche della violenza delle eruzioni, proprio a causa della decompressione improvvisa delle camere magmatiche.
Ma c’è di più. Le eruzioni vulcaniche possono avere un impatto climatico duplice. Se da un lato raffreddano temporaneamente il pianeta riflettendo la luce solare con le ceneri, dall’altro rilasciano gas serra come CO₂ e metano, contribuendo nel lungo periodo al riscaldamento globale. In uno scenario estremo, si rischia un circolo vizioso: più caldo → meno ghiaccio → più eruzioni → più gas serra → ancora più caldo.